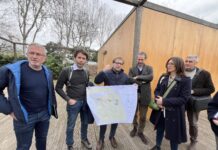Leggo un editoriale di Alberto Alesina sul Corriere della Sera. Solito italiano approssimativo, anzi, più che italiano, italiese (italian + english), soliti pensierini tipo, nome più verbo. Però vi trovo più del solito corbellerie di storia. Decido di citarne una parte ai miei studenti del corso alla Luiss, laurea magistrale (quindi già un po’ senior), scienze politiche, ramo relazioni internazionali. Con mia sorpresa mista a larvata soddisfazione scopro che i miei bravissimi allievi non hanno idea di chi sia Alesina (pure dato come candidato al Nobel dell’economia) e soprattutto mi confessano di non leggere mai il Corriere della Sera. Come gli altri quotidiani, del resto. La saggezza della gioventù.
Se gli studenti di un’università di élite, destinata a promuovere la classe dirigente, vedono i quotidiani come un mondo a parte, di cui si può fare francamene a meno, c’è un problema. Visto che, dopo aver perso l’elettorato popolare (da bambino sui tram milanesi, anni Settanta, vedevo solo copie del Corriere), i giornali si sono indirizzati alle élite.
Ma se pure quelle li snobbano, a chi parlano? Per chi scrivono? A chi si rivolgono? Ha ragione Enrico Mentana a dire che ormai i giornali sono scritti da vecchi per vecchi? Sì, ma il problema sta meno in loro e più nell’establishment di cui i giornali sono specchio o a cui credono di rivolgersi. È la fragilità, la ristrettezza di vedute di questo establishment ad aver privato i giornali di tre delle loro caratteristiche: informare, interpretare, orientare. Non fanno più nessuna delle tre cose: sono però degli ottimi raccoglitori di pagine pubblicitarie.
Il giornalismo della carta stampata come era inteso fino a poco tempo fa, nato nella Inghilterra di fine Settecento, cresciuto nella Francia (anzi nella Parigi) capitale del XIX secolo (Walter Benjamin) e poi plasmato nel Novecento del «secolo americano», è indubbiamente morto o, nel migliore dei casi, moribondo.
Quand’è che, leggendo gli antichi autorevolissimi quotidiani delle capitali del giornalismo mondiale, New York, Washington, Londra, Parigi, Francoforte, abbiamo negli ultimi tempi capito qualcosa? Le clamorose cantonate sull’arrivo della crisi di Lehman Brothers, sulla Brexit, su Trump, per citare solo tre casi macroscopici, ci spingono a dire che anche la vista di New York Times, Wall Street Journal, Washington post, Times, Guardian, Figaro, Monde, Frankfurter Allgemeine Zeitung sembra terribilmente offuscata.
Eppure la loro lettura resta indispensabile per riuscire a conoscere qualcosa: separando il grano dal loglio, saltando articoli che sembrano fotocopie di Repubblica (come avviene da anni al New York times), il quadro emerge dalla neve, qualche contorno si vede. Eppure anche loro non possiedono più i numeri di un tempo, anche loro rincorrono a fatica la distruzione tecnologica, anche loro hanno subito tagli e sono finiti sull’orlo della chiusura (chiedere a Le Monde o al New York times o allo stesso WSJ, salvato da Rupert Murdoch).
Per quanto sia immune dal morbo della esterofilia e del cosmopolitismo, devo riconoscere che il confronto tra il giornalismo “occidentale” e quello italiano è impietoso per il nostro. Per forza, in Francia, in Gran Bretagna negli Usa, in Germania, l’establishment è solido ed essendo solido può mettere in discussione fino a un certo punto anche se stesso; in Italia è un edificio in rovina, i cui inquilini chiudono le tende per non vedere ciò che accade all’esterno.
La crisi del giornalismo è come quella della sinistra: un tema accademico con cui gli addetti ai lavori si rompono il cranio da anni, nel disinteresse di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari: nel primo caso i lettori, nel secondo le classi popolari. Nel frattempo, i primi hanno abbandonato i giornali, le seconde i partiti di sinistra.
In genere le spiegazioni che ci vengono fornite per conoscere questa crisi sono di tre tipi:
a) Sociologica. Ma in realtà para marxista volgare. I giornali sarebbero in crisi perché la condizione economica di chi li realizza è sempre più precaria; così, come dicevano gli extraparlamentari negli anni Settanta, «a salario di merda, prodotto di merda» (mi sia consentita la licenza poetica);
b) Antropologica. L’uomo della iper modernità o della postmodernità è veloce, vuole notizie in fretta, ha perso il senso dell’attenzione, ha una percezione frammentata: i giornali, composti e scritti ancora per l’uomo liberale del XIX secolo o per l’uomo massa del XX secolo, non si sono ancora adeguati, e anzi forse non si potranno adeguare mai;
c) Tecnologica. In parte legata a quella antropologica: la rapidità delle nuove tecnologie, l’avvento di internet, poi dei social, e cosi via, ha offerto al pubblico, spesso in forma gratuita, un universo di informazioni più aderenti alla rapidità dei cambiamenti e anche alle singole esigenze degli individui-pulviscolo.
Tutte e tre queste cause, con le relative concause, possono svolgere i loro effetti, anche se sono più o meno profonde a seconda dei diversi giornali. Esse però spiegano il fenomeno quantitativo, il crollo verticale degli acquirenti dei giornali; non però la frantumazione della loro credibilità, cioè la perdita o nel migliore dei casi l’indebolimento delle tre caratteristiche: informare, interpretare, orientare.
I lettori del New York Times, del Guardian, del Figaro sono ben lontani da quelli anche di un solo decennio fa: ma questo ha inciso solo in parte sulla qualità della loro offerta, che semmai si è raffinata, è diventata più elitaria. Nel caso italiano invece la quantità si è trasformata in (bassa) qualità, il crollo delle vendite è andato di pari passo, in un rapporto di reciproca causa-effetto, con la tracimazione della credibilità dei quotidiani.
Un caveat. Quando qui parliamo di giornali, intendiamo quelli che i piccoli quotidiani chiamano «giornaloni », la stampa mainstream, che in Italia negli ultimi decenni vuol dire Corriere della sera, Repubblica e Stampa.
Quando intendiamo perdita di credibilità ci riferiamo a un effetto di sistema; succede spesso di leggere su quelle colonne pezzi interessanti, acuti, che aprono squarci. Ma sono sempre più rari e sono annegati dal cicaleccio di tutto il resto. Maggiore credibilità e certamente maggior coraggio e curiosità possiedono invece i piccoli giornali, quelli che non a caso rappresentano meno (o per nulla) i settori del vecchio establishment, perché sono contro o incarnano establishment che stanno crescendo.
In questo ventennio di morìa costante dei lettori sono dopotutto nati in Italia molti nuovi «piccoli» quotidiani: alcuni durati lo spazio di un mattino, altri un po’ di più, altri ancora continuano la loro attività e, come si dice in gergo, incidono e fanno dibattito in molti casi assai più di quelli grandi.
E cito, in ordine di età, Il Foglio, Libero, Il Fatto quotidiano, la Verità. Un caso che non ha eguali in altri paesi: il che in teoria dovrebbe smentire la tesi della morte del giornalismo o certamente del disgusto degli italiani nei confronti della forma quotidiano. Evidentemente gli italiani sono disinteressati a leggere, sì, ma giornali che non hanno nulla da dire loro: quando invece le voci sono chiare e nitide, i lettori si spostano o escono “dall’astensionismo” della lettura.
Perché i giornali dell’establishment sono sempre più delle sfingi mute o delle sibille le cui previsioni sono regolarmente smentite dai fatti? Proverò a darne una spiegazione storica, una sociologica e una politica.
La storia. Il giornalismo italiano è sempre stato un parente povero del grande giornalismo occidentale. Chi volesse conoscerne la storia dovrebbe cominciare dai volumi di Paolo Murialdi, dalla strepitosa antologia del giornalismo italiano, i quattro volumi Mondadori curati nel 2007 da Franco Contorbia, e dalla gigantesca, in più tomi, impresa della storia del Corriere della Sera della Fondazione Corriere della Sera.
Leggendo questi testi vediamo come nell’Italia liberale dei primi decenni il giornalismo italiano fosse scarsa cosa, rispetto a quello degli altri paesi, anche se a un livello letterario molto alto. Non a caso alla fine del XIX secolo Alfredo Frassati e Luigi Albertini fecero dei lunghi viaggi, il primo in Germania il secondo in Inghilterra, per importare rispettivamente un modello tedesco e uno inglese (il Times) capace di trasformare quotidiani nati pochi decenni prima, la Stampa e il Corriere della sera, in prodotti moderni, pronti a surclassare in breve tempo, in vendite e in autorevolezza, i vecchi quotidiani.
Il miracolo di Albertini fu, tra i tanti, quello di trasformare il Corriere nel primo vero giornale nazionale, non solo perché diffuso ovunque ma anche perché capace di parlare a tutto il paese. Era la voce di un establishment potente, la borghesia industriale e finanziaria milanese, che stava darwinisticamente mordendo.
Quando dici establishment, dici contro establishment. In reazione ai giornali come Il Corriere e la Stampa, nascevano quelli di partito: l’Avanti!, il giornale del Psi, soprattutto quando fu diretto da Mussolini, negli ultimi anni prima della guerra, schizzò nelle vendite.
Troviamo qui una caratteristica italiana: il peso e l’autorevolezza del giornale organo di partito. Tutti i partiti socialisti europei detenevano organi di stampa ma nessuno come l’Avanti! ebbe in quegli anni la stessa forza che possedeva nel proprio panorama nazionale. Dove c’è salvezza, però c’è anche perdizione. E questa intensa politicizzazione del giornalismo italiano, che è il suo marchio di origine, finirà per condizionarlo sempre.
“La rivoluzione è un’idea che ha trovato baionette”, era scritto sotto la testata del Popolo d’Italia fondato nel 1914 da Mussolini, “La verità è sempre rivoluzionaria” sotto quella dell’Ordine Nuovo creato da Antonio Gramsci nel 1919. Due casi che in piccolo riassumono la storia d’Italia. Due giornalisti, prima ancora che due leader politici, padri di due delle più durevoli culture politiche del Novecento che, prima di organizzare un partito o in attesa di farlo, fondano un giornale – il fascismo di Piazza San Sepolcro nasce dall’esperienza del giornale; il Pcd’I, almeno in parte da quella dell’Ordine nuovo.
Il giornale partito, una forma che ritroveremo, a destra come a sinistra, in tutti i decenni successivi, una tentazione a cui non è sfuggito neanche chi dirigeva giornali che non dovevano essere organi di nulla: Albertini vedeva nel Corriere della sera il partito della borghesia (che non c’era), poi Il Mondo di Mario Pannunzio, Indro Montanelli con il Giornale nuovo, e ovviamente lui, Eugenio Scalfari con Repubblica. Persino Togliatti, che un partito l?aveva e lo stava ricostruendo, volle che l’Unità non fosse un suo mero organo: doveva essere il «Corriere della Sera del proletariato».
Il marchio della politica: la verità è sempre rivoluzionaria, ma nel senso che vero è ciò che afferma il mio “partito” e che a questi serve. E poi la convinzione che l’idea debba essere al servizio delle baionette (metaforiche ma non solo).
La politicizzazione del giornalismo viene amplificata con il fascismo, che trasforma tutti i giornali in organi di regime: cioè in strumenti di battaglia politica. Essendo tuttavia il regime attraversato da tendenze in forte contrasto tra loro, lo scontro politico interno, non potendosi attuare nel Partito fascista o nel paese, finisce per tracimare nei diversi giornali, ognuno rappresentante di una idea e di una pratica di fascismo diversa da quella degli altri.
A questo punto la storia procede su di un piano inclinato: la Guerra Fredda militarizza il giornalismo, e quando comincia la distensione, arriva il Sessantotto, che prende d’assalto i giornali mainstream tiepidi o ostili (sempre da leggere il classico L’eskimo in redazione di Michele Brambilla).
In breve tempo negli anni Settanta Il Corriere della Sera e il Messaggero vengono strattonati a sinistra, mentre la Repubblica nasce proprio per regalare un organo di riferimento al nuovo e vasto popolo rosso generato dalla lunghissima contestazione. I giornalisti formatisi in quegli anni, con una mentalità fortemente ideologizzata e al tempo stesso vocata al machiavellismo, saliranno i gradini della corporazione negli anni successivi: e anche se non crederanno più in Lenin-Stalin-Mao, la loro forma mentis non cambierà. Quando poi, con la fine della Guerra Fredda, sembra giunta una pacificazione, ecco comparire il Cavaliere nero, Berlusconi. E la guerra ricomincia.
Quando gli stranieri si chiedono come mai nei nostri quotidiani prevalgano le pagine di politica interna, con il «retroscena», genere inesistente altrove, e invece quelle di esteri, su cui è più difficile impostare un approccio ideologico, siano poche e mal fatte, l’origine è da cercare nella vocazione del giornalismo alla politicizzazione.
Da qui il linguaggio criptico e allusivo, le metafore fruste, i cronisti non solo di partito ma persino di corrente, i soli preposti a intervistare il loro capo bastone di riferimento, da qui l’estero, l’Europa e il mondo, sono raccontati attraverso le ristrette e provinciali coordinate della politica interna, da qui il puntare su leader stranieri perché potrebbe favorire quello interno a cui si è più vicini in quel momento, da qui la costruzione di mondi fantastici e immaginari, da qui le previsioni buone più a lenire le pene del ceto politico e dei lettori a cui in quel momento il giornale guarda. Siamo ancora tutti figli di Mussolini e di Gramsci.
Spiegazione sociologica. Il giornalismo è uno dei capisaldi di quella che Jurgen Habermas definisce sfera pubblica borghese che, nel corso del Novecento, viene progressivamente sostituita dalla società di massa, che è in realtà una società di ceti medi e di ceti popolari, con questi ultimi sempre più progressivamente assorbiti dai primi.
Questa società di massa modifica radicalmente la sfera pubblica borghese, che incomincia a incrinarsi, sul piano dei valori, dagli anni Sessanta del secolo scorso, quando al posto del vecchio individuo borghese (a cui si conformavano anche i ceti medi e quelli popolari) si afferma un individuo desiderante, l’individuo narcisista: la sfera pubblica comincia a rompersi perché viene via via meno il pubblico, cioè la comunità, rimpiazzata sempre più da un pulviscolo di individui dai legami sempre più laschi tra loro. In seguito, la globalizzazione e poi la crisi del 2008 incrinano la società dei ceti medi. Il giornale era la voce al tempo stesso dell’individuo e della società, ma di una società che non si limitava a essere solo una raccolta di atomi e possedeva ancora forme e gerarchie precise.
La fine della società dei ceti medi e l’estendersi dell’individuo narcisista hanno indebolito la funzione del giornale. Un fenomeno avvenuto in tutto il mondo occidentale: ma l’Italia ne è stata colpita di più per il carattere già fragile dei suoi legami sociali, per la recente formazione di questa società dei ceti medi, a cui il paese, come mostrò a suo tempo Paolo Sylos Labini, era arrivato nel giro di pochi decenni, appena uscito dalla realtà contadina. In una società destrutturata di individui destrutturati, ai giornali non resta che rinchiudersi in ristrette, e sempre più autoreferenziali, clientele, le une scarsamente comunicanti con le altre.
Spiegazione politologica. I giornali sono la voce e al tempo stesso uno dei nervi dell’establishment. Confessiamo però che questo termine, che pur va usato a fini polemici e di battaglia, non ci convince: al di là di costringere all’uso della lingua inglese, non è un concetto che consenta di analizzare a fondo, rimanda all’idea di un blocco compatto e infine porta con se sempre connotazioni dal vago sapore cospirazionistico.
Introdotto, nel suo uso contemporaneo, dal giornalista inglese Henry Fairlie negli anni Cinquanta, il concetto di establishment è stato infatti diffuso dallo storico americano delle cospirazioni Quigley Carroll – di cui ha parlato su List Lorenzo Castellani.
Meglio, molto meglio usare il termine di ruling class, cioè di classe dominante, intesa nel senso di Gaetano Mosca. Le classi dominanti del vecchio Occidente stanno attraversando una fase di trasformazione, di confronto e scontro interno, mentre nuove classi cercano di rimpiazzare le vecchie, che resistono o tentano di trasformarsi in nuove.
Questo processo sta avvenendo anche in Italia, dove però le classi dominanti (anche questo è un retaggio storico) sono sempre state più deboli, meno established di quelle degli altri paesi occidentali, sul piano della legittimazione formale e ancor più di quella sostanziale, sul piano dell’esercizio effettivo del potere come su quello della gestione del capitale simbolico.
Tanto che le classi dominanti italiane hanno avuto sempre bisogno di un controllo diretto sui giornali (la famosa questione dell’assenza dell’editore puro), utilizzati al tempo stesso come mezzo di contrattazione e di scambio politico nei confronti delle altre classi dominanti (la classe politica strettamente intesa) e come viatico per influenzare l’universo ideologico delle classi che vorrebbero diventare dominanti e dei ceti subalterni.
La debolezza e quasi l’insicurezza di larga parte delle classi dominanti ha prodotto un establishment – se vogliamo continuare a usare questi termine – impaurito, chiuso in se stesso, particolarmente incapace di prevedere il futuro.
Una miopia che i giornali, che di queste ruling class sono lo specchio più ancora che il megafono, a loro volta riproducono. Già, il prevedere. Scriveva Benedetto Croce nel 1904, «ciò che chiamiamo prevedere, non è altro che un modo immaginoso ed enfatico per esprimere non già il futuro di cui non sappiamo e non possiamo sapere nulla e che non è materia di conoscenza, ma il presente: non è dunque un pre-vedere ma è un vedere.
“I preveggenti sono i veggenti: coloro che hanno buoni occhi per scorgere in ogni suo tratto la realtà attuale”. E oggi gli occhi delle classi dominanti italiane in declino, se non sono chiusi, sono stati colpiti da una forte cataratta: che le fa vagare a zonzo fino a spaccarsi la testa contro ogni lampione.
I giornali dell’establishment, che dovrebbero fare da guida, non sono di aiuto: anzi, convinti ormai di dovere, più che convincere, confermare nelle loro credenze una fascia sempre più ristretta di aficionados, essi spingono ancora più l’establishment verso il baratro. Mentre si intravedono nuove, barbariche, ruling class che premono alle porte.